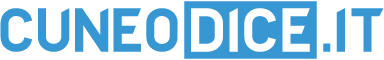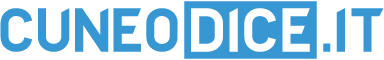In quel deserto di proposte che si è rivelata essere la campagna elettorale nei primissimi giorni, ha fatto discutere un’idea lanciata da Carlo Calenda. In occasione della presentazione alla stampa estera del Patto Repubblicano, il cartello elettorale tra la sua Azione e Più Europa, l’ex ministro ha detto: “Ci impegniamo a non candidare a posti di governo chi non ha avuto rilevanti esperienze amministrative o gestionali nel pubblico o nel privato. Uno dei punti di metodo rilevanti dell’agenda che presentiamo è il ripristino del principio di cursus honorum”.
A chi ha qualche reminiscenza scolastica sull’antica Roma il concetto dovrebbe suonare familiare. Il “cursus honorum” era il percorso che ciascun politico doveva affrontare per ascendere alle massime cariche dello Stato. La carriera dell’uomo pubblico era così scandita per tappe, in ordine crescente di importanza e - a partire dal 180 a.c. - secondo i vincoli di età stabiliti dalla lex Villia annalis. Il primo passo era l’elezione a questore, per cui i candidati dovevano aver compiuto 24 anni. Dalla questura si poteva essere eletti al Senato. I questori a fine mandato dovevano attendere un anno per accedere a una carica più elevata, quella di tribuno della plebe o edile. Ancora più in alto stavano i pretori e infine i consoli: chi aveva servito come pretore, trascorsi due anni, poteva ascendere al consolato, la suprema magistratura. In assenza di un concetto moderno di “rappresentanza” del popolo, estraneo alla civiltà romana, questo sistema serviva comunque a garantire un certo equilibrio tra patrizi e plebei - e soprattutto ad assicurare la preparazione della futura classe dirigente.
Calenda, erede orgoglioso della romanità antica (tanto da tatuarsi la scritta Spqr su un polso), non ha spiegato nel dettaglio come intenda disciplinare il rinnovato “cursus honorum”. Nell’ultimo dei quattordici punti programmatici del Patto Repubblicano si dice solo “ci impegneremo a candidare ai principali posti di governo solo persone con rilevanti esperienze gestionali e amministrative maturate nel settore pubblico (sindaci, presidenti di regione) o privato”. A voler essere perfidi, si potrebbe notare che la postilla dove si equipara il “settore privato” a quello pubblico è vaga e pare tagliata su misura per lo stesso Calenda, passato da assistente di Montezemolo in Confindustria a candidato (trombato) con Scelta Civica, quindi viceministro e poi ministro. Tutto questo senza alcuna esperienza pregressa negli enti locali.
Ma la questione posta dal leader centrista è seria e meriterebbe di essere vagliata. Nel 1993 gli italiani abolirono con un referendum, voluto da Segni e dai Radicali di Pannella, la legge elettorale proporzionale. Si era agli sgoccioli della cosiddetta prima repubblica e le preferenze per i parlamentari, allora in auge, erano considerate uno strumento di perpetuazione del sistema corrotto e clientelare. Quello che si è visto in seguito, però, vale quasi a farci rimpiangere l’epoca in cui il sindaco monarchico di Napoli Achille Lauro si assicurava il voto con un paio di scarpe per famiglia, consegnandone una prima dell’elezione e l’altra dopo. Numerosissimi sono stati i candidati estranei ai territori o con scarso consenso personale “paracadutati” in collegi blindati: l’ultima volta fece sorridere il caso dell’aretina Maria Elena Boschi, spedita dal Pd renziano a Bolzano, ma c’è da credere che non ne mancheranno di analoghi in questa tornata (per giunta condizionata dal taglio di oltre 1/3 dei seggi).
Uno, in particolare, potrebbe riguardare la provincia di Cuneo. A rigore non sarebbe una novità ma un ritorno, quello di Daniela Santanchè: si mormora che la senatrice oggi in Fratelli d’Italia, cuneese di origine ma altrove residente fin dagli anni Ottanta, potrebbe essere ricandidata in un collegio diverso da quello di Cremona, dove era stata rieletta nel 2018. Quale? Quello di Cuneo, appunto, nel quale la “pitonessa” sponsorizzata da Ignazio La Russa mantiene famiglia e contatti. Ma dove, tuttavia, non si è mai misurata alle urne nella sua ormai più che ventennale carriera parlamentare. Dal punto di vista del “cursus honorum” sono messi meglio gli attuali deputati e senatori della Granda. Tre di loro sono addirittura sindaci in carica (Monica Ciaburro ad Argentera, Flavio Gastaldi a Genola, Marco Perosino a Priocca), un quarto - Giorgio Bergesio - lo è stato per un decennio a Cervere. Altri, pur senza mai vestire la fascia tricolore, hanno maturato più o meno lunghe esperienze nelle amministrazioni locali: Enrico Costa e Mino Taricco in Consiglio regionale (quest’ultimo anche in giunta), Chiara Gribaudo come consigliera comunale e assessore a Borgo San Dalmazzo. La sola Fabiana Dadone, in ossequio alle regole imposte dal suo movimento, è passata dalle “parlamentarie” al parlamento senza precedenti incarichi in ambito locale.
Se non si vuole tornare alle preferenze e ai possibili inconvenienti che potrebbero derivarne, imporre a chi aspira a governare il Paese (con la maiuscola) almeno un mandato da consigliere “di paese” potrebbe, forse, riavvicinare la classe dirigente ai territori. Familiarizzando i futuri onorevoli con le classiche questioni legate alle buche nelle strade, allo sgombero neve o alle varianti da far approvare in consiglio comunale: tutte esperienze che gioverebbero anche a chi si senta chiamato a più alti destini. Ma soprattutto, riducendo il rischio che al momento di votare per i loro rappresentanti a Roma gli elettori si trovino nella condizione descritta da Giorgio Gaber, nel suo monologo sulla democrazia: “Deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato, che tu non sai chi è, e che tu deleghi a rappresentarti per cinque anni. E che se lo incontri, ti dice giustamente: ‘Lei non sa chi sono io’”.