La cronaca è cronaca: non arroghiamoci il diritto di pensare al posto dei lettori
È lecito indicare anche la provenienza di indagati e colpevoli di reato? Noi rispondiamo che il nostro lavoro è informare: purché si stia ai fatti, non ai (pre)giudiziC’è un’antica storiella iraniana che racconta del viaggio di un vecchio e un bambino insieme a un asino. L’anziano e il figlioletto vengono dapprima rimproverati dagli abitanti di un villaggio, perché il bambino è in groppa all’asino mentre il povero vecchio è costretto a camminare. Nel villaggio successivo il padre sale sull’animale e il figlio va a piedi: “Che vergogna - dice chi li vede passare - quel vecchio egoista lascia che un bambino si affatichi”. Quando entrambi decidono di montare in groppa al somarello, chi li vede si indigna: “Quella povera bestia si sfiancherà!”. Alla fine, i due si rassegnano a fare a piedi il resto del cammino, derisi da tutti coloro che li incrociano: “Che assurdità, hanno un asino e vanno a piedi!”.
La morale della favola è abbastanza evidente: non c’è modo di fare qualcosa senza scontentare qualcuno. Nel nostro lavoro, poi, diventa pressoché impossibile. Ce ne accorgiamo leggendo i commenti social e i messaggi che accompagnano molti articoli di cronaca: per alcuni le informazioni sono sempre poche, per altri troppe. A volte si assiste perfino al paradosso di trovare commentatori insoddisfatti per un motivo e per quello opposto, sotto lo stesso post. C’è chi si scandalizza del fatto che “non mettete i nomi” (per inciso: le informazioni sulle operazioni di polizia e carabinieri arrivano quasi sempre dalle forze dell’ordine, sono loro - previa approvazione della procura - a decidere se i nomi vadano indicati o no). C’è chi si ritiene diffamato dalla narrazione di fatti ascoltati in tribunale - Tizio ha affermato, Caio ha replicato, il giudice ha sentenziato - anche quando non ci siano riferimenti ai protagonisti. Inutile chiedersi chi abbia ragione, nel momento in cui ad esprimersi è una sensibilità personale e ognuno, vivaddio, ha diritto alla sua.
Un caso a parte, lo sappiamo, è quello che riguarda la presenza di stranieri e italiani nella cronaca nera e giudiziaria. Questione delicatissima, perché tocca le basi della convivenza civile, in una società sempre più multietnica e multiculturale. Cosa fare? Molti colleghi ritengono, in buona fede - e anzi, probabilmente senza nemmeno porsi il problema in questi termini -, che la pace sociale valga di più dell’informazione: meglio non menzionare certi particolari se si teme che possano instillare pregiudizi, “sopire e troncare”. C’è anche, del resto, chi specula in maniera indecorosa sulle stesse circostanze, alimentando una spirale di odio nei confronti di molti, a causa delle azioni esecrabili di pochi: la retorica delle “solite risorse”.
Noi riteniamo che proprio per evitare tutto questo sia opportuno limitarsi ai fatti: se abbiamo un’informazione la diamo, perché dare informazioni è il nostro lavoro e perché un’informazione in più è meglio di una in meno. Fatti salvi - è ovvio - i casi che richiedano una cautela particolare a tutela delle vittime, delle altre persone coinvolte, degli stessi indagati. Parliamo di reati che abbiano a che fare con i minori, crimini sessuali, violenze familiari: tutte questioni che del resto la deontologia già provvede a normare.
L’alternativa indicata come più virtuosa è in realtà più insidiosa, dal momento che finisce per alimentare sospetti - legittimi, a questo punto - in coloro che leggono: il dubbio che chi scrive non stia dicendo tutto, che voglia tenere per sé qualcosa, non perché ciò sia necessario a tutelare principi sacrosanti (la presunzione d’innocenza, la privacy delle vittime, lo svolgimento delle indagini), ma per altri motivi. In generale, perché un certo numero di giornalisti ormai pensano che i lettori vadano prima educati e solo dopo informati. E questo, purtroppo, corrisponde al vero: mi sovviene una frase scritta anni fa da una brava collega torinese - brava per davvero, una di quelle che le notizie le cercano “consumando le suole” - su una violenza in Barriera Milano. L’episodio era descritto così: “Aggressione ad opera di due uomini, ferito un connazionale”. A tanto siamo ridotti: possiamo decidere di chiamarlo “politicamente corretto” o in un altro modo, se l’espressione non piace. La sostanza è la medesima.
È pericoloso, appunto, perché il nostro lavoro si basa sulla fiducia: al pubblico noi stiamo dicendo che un certo fatto si è svolto in un certo modo, o perlomeno che così ce lo hanno raccontato fonti affidabili. Se chi ci legge smette di crederci, il patto tra giornalista e lettore si infrange. Un esempio vicino: qualche settimana fa si è verificato un duplice scippo a Cuneo, nella zona di corso Giolitti. Quando abbiamo dato la notizia non sapevamo nulla più di questo: né l’età, né la provenienza, né la residenza dell’autore. Eppure in molti hanno dato per scontato che tacessimo qualcosa. Non era così, e per la cronaca, lo scippatore - un tossicodipendente - era piemontesissimo: altro che “solite risorse”. Se l’avessimo saputo subito, anziché a distanza di tempo, avremmo tolto il dubbio anche ai malpensanti.
La menzione di determinati dettagli, a nostro giudizio, diventa scorretta solo quando viene posta in termini disonesti. Quando si generalizza, si insinua, si giudica prima che il verdetto l’abbia emesso un tribunale. Se ciò non avviene, il cronista non deve sentirsi investito del diritto di decidere, al posto dei suoi lettori, se sia opportuno far sapere che l’indagato è un ventenne gambiano fermato in corso Giolitti o una cinquantenne italiana arrestata in viale Angeli. La cronaca è cronaca: basta stare ai fatti, lasciando da parte giudizi e pregiudizi.
Andrea Cascioli
 CUNEO
CUNEO immigrazione - giornalismo - media - Cronaca - criminalità
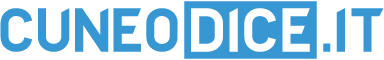

 Condividi
Condividi