Dentro l’atelier di Gian Piero Viglino
L’ideatore del veliero sul prato di Mombarcaro ricerca il ritmo dei battiti del cuore, “metronomo perfetto” delle sue opereGian Piero Viglino è il creatore di “Libera”, veliero che affiora come un relitto su un prato di Mombarcaro, dove è stato inaugurato lo scorso agosto. Un’installazione che è metafora dell’esistenza. Un tema quello dell’esistenza che l’artista, nato ad Alba nel ‘51, esplora anche nella ricerca pittorica. Vedere un’opera di Viglino è fare un’esperienza.
Vedere non guardare: tra i due vocaboli c’è una differenza enorme. Entrare nel suo studio, in un’abitazione ubicata nel centro di Dogliani, e sedersi sulla sua poltrona gialla, posizionata davanti al quadro a cui sta lavorando, alla giusta distanza per poter cogliere nella tavola bianca il ritmo e capire il gesto che darà origine all’opera, è davvero fare un’esperienza.
Stare seduti su quella poltrona ha del misticismo. A sinistra le finestre che affacciano sul Rea, un affluente del Tanaro. Quel Tanaro che nel 1994 portò via con sé anche lo studio di Viglino, allora a Moriglione, ai pedi di Novello. All’interno dell’atelier un caos di cavalletti, colori acrilici, tempere, vernici, una radio, perché Viglino lavora sempre ascoltando la musica, che da buon batterista ha dentro, e vecchi giornali che dopo aver svolto il loro compito, breve l’esistenza delle notizie, assolvono ad altre funzioni come preservare il pavimento o una superficie dagli schizzi di colore.
Tornando alla poltrona, bastano pochi minuti di concentrazione sull’opera appesa al muro bianco, sporcato dagli schizzi di colore, da alcuni appunti e da una frase - “Non basta una buona vista per vedere, ci vuole il cuore puro” - che subito il quadro ti entra dentro e tu entri nel quadro. E i battiti del cuore di Viglino si mischiano con le pulsazioni del cuore di chi sta osservando. Mentre gli occhi vagano sulla tavola, c’è un preciso istante in cui ti rendi conto che quei rossi, quei verdi, quei neri, sono vivi, quei gesti sulla tela si animano. Non è così facile stare lì seduti: il colore si fa musica inquieta e smuove diverse corde, a seconda che lo si osservi nella penombra più rassicurante o nello schiaffo della luce accesa di un faretto. Non è una pittura per tutti. Al giorno d’oggi, violentati continuamente da immagini che scorrono velocissime, non siamo più abituati a vedere. E a volte è più facile non farlo.
Come ti sei avvicinato alla pittura?
“Fin da bambino amavo giocare con i colori ma prima della pittura ho sempre avuto il ritmo. A 2 anni d’età giravo battendo sulle pentole con i cucchiai di legno per il paesino del Torinese dove abitavo. Mia mamma doveva venire a recuperarmi. Crescendo mi sono avvicinato alla pittura, abbandonandola quando ho iniziato a suonare all’età di 14 anni. In quel periodo sono arrivate le prime band. Nei ‘60 ne avevo una dove suonavamo rhythm and blues ma la sera prima di firmare un contratto importante ci rubarono tutti gli strumenti. Questo scherzo del destino ha segnato l’inizio del mio viaggio nella pittura”.
Che cos’è il ritmo che cerchi nella tua opera? Nelle opere di grandi dimensioni come nei tuoi più recenti piccoli camei.
“Per me è tutto legato al ritmo. Non c’è azione, momento di vita o emozione che non sia legata a un ritmo. Il ritmo è l’essenza. Se ci pensi bene, quello che fa vivere noi e il mondo è il ritmo del cuore. È un ritmo estremamente importante, e non solo per le ragioni vitali, perché a seconda dell’emozione che stai vivendo, e non te ne rendi conto in quel momento perché appunto la stai vivendo, hai un ritmo dentro che cambia continuamente. E lo vivi come fosse una colonna sonora della tua vita: se sei triste sei sul blues, se sei melanconico vai sulle ballad, se sei allegro vai sull’effervescenza del jazz anni ‘30-’40 e così via”.
Come nascono i tuoi quadri?
“Ho un rapporto molto zen con la superficie che andrò a dipingere. Tutti i miei pezzi partono da un gesto, poi la lavorazione viene man mano in un intreccio di volontà e caso. Di solito parto con un’idea, ma fino a quando non trovo questo inizio non riesco a incominciare. Posso passare ore, a volte giorni, seduto alla mia postazione in cerca del ritmo, dell’essenza. Quando lo trovo stendo una pennellata iniziale, che è sempre molto gestuale, e costruisco il dipinto su questa sciabolata di colore. Nella prima parte di lavorazione procedo con una pennellata libera, poi cancellata da sovrapposizioni continue e casuali con utilizzo di stencil. Il risultato è un insieme di gesti e segni. La cancellazione è fondamentale perché fa affiorare l’essenza, quello che il quadro ha già dentro di sé, quello che l’opera deve essere. A volte neanche io so esattamente cosa sia ma lavorando scopro ciò che deve emergere e ciò che va cancellato. Se ci pensi l’esistenza stessa è un insieme di cancellazioni e sovrapposizioni: cancelli errori e parti di te che non ti piacciono e sovrapponi gioie e conquiste. E in base a questo l’idea iniziale cambia continuamente perché un giorno sei triste, un altro felice, un altro ancora arrabbiato. Questa somma di emozioni fa la vita e quindi anche l’arte”.
Nelle tue opere, citando la PFM, c’è “un uomo in cerca di se stesso”?
“Sì, ma in fondo non lo siamo tutti? Nel mio lavoro è fondamentale la concentrazione, che per me è quel momento in cui, dopo aver lavorato a una parte del quadro, torno sulla poltrona e lo guardo di nuovo, nell’insieme, attentamente, per alcuni minuti. A volte possono diventare ore. È un momento importantissimo perché ti fa capire in quale direzione devi andare. Perdere questa concentrazione significa rischiare di fare mero decorativismo, ma non è quello che cerco. Per me è essenziale che ogni tassello sia incastonato alla perfezione, e non perdere il ritmo. Come in un brano musicale dove sono importanti le note ma anche le pause. Può succedere che, durante la lavorazione, arrivi a un punto in cui non riesca più a continuare e allora tolgo il quadro dalla postazione di lavoro e lo appendo alla parete, con la superficie dipinta girata contro il muro. Può stare lì a “decantare” anche per mesi. Poi arriva il giorno in cui decido di riprenderlo, girarlo e, esaminandolo seduto sulla mia poltrona, in poco tempo, trovo la conclusione. Raramente mi è successo di iniziare un quadro e portarlo al finale in un colpo solo senza attraversare questo processo”.
Nei tuoi lavori vuoi portare i battiti del cuore, un “metronomo perfetto”. Qui c’è l’influsso del tuo essere anche batterista. Ci sono analogie con la pittura?
“Sì. E con presunzione, vorrei portare nell’opera anche i battiti di chi la guarda. È bellissimo quando mi fanno scoprire angolazioni che non avevo visto o sensazioni e emozioni che io non avevo sperimentato, nonostante io abbia lavorato a quel pezzo per ore, mesi e, a volte, anni. Per quanto riguarda la batteria e la pittura, conoscendo entrambi i linguaggi, posso dire che ci sono diverse analogie perché in fondo sono entrambi un’esplorazione. Come il batterista cerca di mettere dei colori nel suono, io cerco di mettere del ritmo nel colore”.
Quella sul paesaggio è una ricerca che porti avanti da fine anni ‘80: un paesaggio astratto, visionario, onirico, surrealista fatto di segni e colori indefiniti. L’indefinito, per te, è una cifra importante.
“Sì, perché quando guardi un paesaggio filtrato da elementi come l’alba, il tramonto o la nebbia, che ne sfumano tutti i contorni, a un certo punto tu non lo guardi più ma lo senti. Lo guardi con l’anima. L’indefinito ti porta all’essenza delle cose e a coglierne l’anima”.
Ora che ci penso ho sperimentato una sensazione di questo tipo in mattinata, in Langa, mentre guidavo per raggiungerti nel tuo studio. La potrei definire un’esperienza pittorica perché non mi tornano in mente i contorni o le forme ma i blu, i verdi, il bianco. E le emozioni provate.
“Sì, hai colto quello che stavo dicendo. Il paesaggio esalta l’anima quando è indefinito, un po’ come la musica. In quei momenti vivi dentro di te una guerra di emozioni e il paesaggio lo stai facendo e lo stai dipingendo tu”.
Il gioco, e la componente di curiosità e immaginazione a esso legate, sono da sempre presenti nel tuo lavoro. Dai primi gessi e ossidi su tela in iuta, dove lanciavi i colori a distanza come se stessi giocando a freccette, fino a “Libera”, il veliero costruito insieme a una ciurma di amici dove l’arte diventa gioco di squadra.
“Sì, quella del gioco è sempre stata la componente principale e voglio che continui a esserlo. Prima di tutto io voglio divertirmi e il momento in cui creo deve essere divertimento puro. Se c’è una sofferenza quella viene prima o, eventualmente, dopo perché non sei riuscito a portare a compimento l’idea come avresti voluto. Ma il momento della creazione è gioco e liberazione. Alcuni miei ultimi lavori, su carta, sono nati come non sense, come gli scarabocchi dei bambini. Quello che mi intriga è il fatto che il senso, casuale e non voluto, viene trovato da chi lo guarda, insieme alla possibilità di riappropriarsi della piacevolezza del gioco dei bambini senza avere l’obbligo di dare una spiegazione”.
Francesca Barbero
 DOGLIANI
DOGLIANI alluvione - Dogliani - arte - Mombarcaro - Gian Piero Viglino
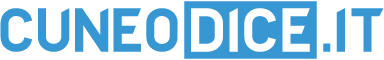

 Condividi
Condividi