La magia del Sol Invictus si ripete alla Casnea di Briaglia
Nel giorno del solstizio d’inverno una lama di luce percorre l’intera galleria poco dopo l’alba. La “Newgrange italiana” resta un mistero archeologicoSuccede ogni anno tra il 21 e il 22 dicembre, quando una lama di luce colpisce il fondo della Casnea di Briaglia, un cunicolo ipogeo la cui origine storica resta un mistero per gli archeologi.
La chiamano la “Newgrange italiana”, perché un fenomeno analogo si verifica in un tumulo neolitico irlandese, costruito intorno al 3.200 avanti Cristo e perciò ancora più antico di Stonehenge. A Newgrange, patrimonio dell’Unesco, si ritrovano ogni anno migliaia di persone per assistere al “rito” del solstizio: il sito è inavvicinabile, a meno di non prenotare con mesi o anni di anticipo.
L’ipogeo di Briaglia non è altrettanto famoso e frequentato, anche se la sua notorietà è cresciuta a partire dal 2012, quando sono stati effettuati nuovi scavi e una serie di lavori per renderlo accessibile. Dall’esterno si vede una porticina con architrave, seguita da un corridoio rettilineo con due camere e una cisterna. All’interno c’è una specie di arcosolio, somigliante alla classica tipologia delle tombe etrusche ed egizie. L’area è privata e chiusa al pubblico da un cancello, ma è possibile visitarla partecipando alle iniziative del Comitato Landandé. Questa mattina, intorno alle otto, si erano radunate un centinaio di persone: il Sol Invictus non le ha deluse, malgrado un’iniziale foschia. Intorno alle 8,30 il pennello di luce, spuntato da una forcella tra i monti, si è proiettato per alcuni minuti sulla falsa porta che chiude il corridoio, dopo circa 15 metri di galleria.
Piero Barale e Laura Sciolla sono i protagonisti della “riscoperta” della Casnea. Il primo a penetrarvi, nel 1971, era stato il professor Ettore Janigro D’Aquino. I giornali locali diedero ampia pubblicità alla clamorosa scoperta di quello che l’archeologo casalese riteneva essere un dolmen - cioè un sepolcro megalitico - innalzato dai Liguri Bagienni. Janigro D’Aquino proseguì nei decenni successivi le sue ricerche, collezionando materiali che erano a suo parere steli e manufatti umani. Fantarcheologia, ha sempre ribattuto la Soprintendenza: “Janigro pensava che le pietre raccolte fossero state create da mano umana, poi si è scoperto che sono invece modellate dalla natura: non è detto però che lo siano tutte” sostiene Barale.
Il sito venne abbandonato e quasi dimenticato, dopo essere stato derubricato a un semplice crutin per la conservazione dei cibi o a una cava. Le più recenti indagini hanno smentito entrambe le ipotesi, con l’ausilio di perizie fornite da geologi e ingegneri minerari: “Ci stiamo sempre più rendendo conto che questo è un luogo particolare, anche se non un dolmen come si pensava ai primordi”. La datazione resta però molto incerta: i reperti più antichi scavati nel 2012 risalgono al periodo medievale, con ceramiche del V-VI secolo e altri oggetti fino al XIV secolo. “Era un luogo frequentato probabilmente per la raccolta dell’acqua, dopo essersi trasformato in una cisterna sotterranea” spiega ancora Barale. Il toponimo Casnea richiama il termine “casna”, radice indoeuropea della parola “quercia”, suggerendo un collegamento con un bosco sacro.
Quel che è pressoché certo è che la sua collocazione non è frutto di una felice casualità: gli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica stimano tra 0,6% e 1% le probabilità in questo senso. L’ipogeo è quindi “un unicum anche dal punto di vista del fenomeno solare”, conclude Laura Sciolla. Ed è proprio il sole che potrebbe fornire un indizio sulla sua datazione: l’altezza a cui sorge in questo momento, dice Barale, “non corrisponde esattamente all’asse dell’ipogeo. Il sole si trovava allineato al corridoio nel 3000 a.c., ma non abbiamo elementi datanti che dimostrino l’esistenza dell’ipogeo già cinquemila anni fa”.
Un altro mistero è legato alla presenza di ocra rossa sulla parete al fondo della camera, notata già negli anni Settanta da Janigro. Il dipartimento di Scienze della Terra dell’università di Torino l’ha analizzata e ha scoperto che si tratta di cinabro: un minerale che veniva utilizzato come elemento sacrale a scopo funerario e che non si trova in nessun luogo circostante. Il punto di provenienza più vicino è il monte Amiata, nell’Appennino toscano, cosa che suggerisce collegamenti con la civiltà etrusca. Questione da indagare, così come si intende fare per approfondire la rifrazione della luce sull’acqua della cisterna: “Gli studi sono proseguiti anche in altri ambiti, sulla geobiologia e il suono dell’ipogeo” sottolinea Sciolla, precisando che quello spazio “è un luogo con energie molto elevate, in particolare durante il solstizio”. Solo poche settimane fa alcuni ricercatori hanno rilevato nell’ipogeo una frequenza di 101 hertz, molto vicina ai 110 hertz di Newgrange. Nella camera di fondo i tecnici del suono hanno emesso una nota unica, sol e do, scoprendo che veniva amplificata dalla struttura per effetto di rifrazione tra le pareti. L’ipotesi è che il riverbero potesse essere utilizzato per scopi rituali dai misteriosi costruttori.
Andrea Cascioli
 BRIAGLIA
BRIAGLIA Briaglia - Archeologia - solstizio - Casnea - Ettore Janigro D'Aquino - Piero Barale - Laura Sciolla
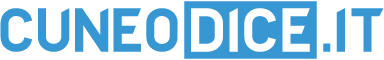





 Condividi
Condividi