Un albese sulle tracce di Ezra Pound
È uscito “Pena di me stesso. Debolezze Scanzonate”, ultimo lavoro del poeta Paolo Pera, originario di Canale. Il giovane ha conosciuto Mary, la figlia dell'autore dei celebri “Cantos”É uscito “Pena di me stesso. Debolezze Scanzonate” (Ensemble edizioni, 2022), quarto libro di Paolo Pera, giovane poeta albese (classe 1996), originario di Canale. Il libro completa il dittico inaugurato da “Pietà per l'esistente. Satire e poesie censurabili”. Se nella prima anta del dittico il poeta scagliava le sue frecce contro la “bruttezza” di un mondo corrotto, qui il bersaglio è il poeta stesso: un poeta innamorato e amante, un poeta studente, un poeta figlio che confessa colpe, carenze e debolezze con tono scanzonato. Nei suoi versi il lettore troverà anche l'amore per il suo primo grande maestro: Ezra Pound. Una devozione che l'ha portato fino a Brunnenburg, a conoscere la figlia dell'autore dei “Cantos”.
Pena di me stesso. Debolezze Scanzonate completa un ideale dittico aperto con la raccolta poetica precedente, Pietà per l'esistente. Satire e poesie censurabili. Nella prima anta il poeta dall’inferno lancia strali verso un mondo esterno marcescente, alla deriva, afflitto dalla "peste del 2000", corrotto, senza morale (non si salva neanche la religione), individualista e schiavo delle ossessioni contemporanee come il culto del corpo. Quindi, nella seconda parte, il discorso si fa introspettivo e il bersaglio della satira sferzante diventa il poeta stesso.
"Mi pare che tu sia riuscita a restituire un buon flash del mio dittico. Dopo ormai due anni dalla nascita di queste poesie (primavera-autunno 2020) ne ho forse capito l’entità. Il tutto, a una lettura attenta, dovrebbe risultare (poi chissà) un percorso dal di dentro dell’io, verso una sua modificazione: abbiamo, in principio, una voce poetante che presenta alcune complicanze (misantropia, insofferenza, corrosività e un avvilimento dato dal dubbio cartesiano: sono corpo e mente a un tempo?). Per di più, essa, potrebbe essere tacciata, com'è successo, di razzismo, quando non di più generale xenofobia. Insomma un soggetto narcisistico, diciamolo (à la La Russa in versione Fiorello), però interiormente in lotta, e quindi vergognoso del suo stesso modo d’essere al mondo. E questo si verrà infatti a manifestare nel rapporto con il sentimento della pietà".
La pietà è un sentimento che implica la partecipazione al dolore di chi sta soffrendo. La pena è afflizione e sofferenza morale. In "Pena di me stesso. Debolezze Scanzonate" il poeta ha compassione per la sua sofferenza?
“La pietà per l’esistente, di fatto, era anzitutto un dire all’esistente 'mi fai pietà', un disprezzo per quella 'bruttezza desiderata' (in varie forme) che l’io poetico incontrava nell’altro da sé. L’autoanalisi che faccio ormai da un po’ su questo lavoro, mi ha portato a capire che sotto quello sprezzo stava però una compassione. Basterebbero due esempi: si consideri la poesia 'L’estetica del manichino' e poi 'Il compassionevole'. La prima mi fruttò un'accusa di misoginia, per di più, bello. Ecco, 'L’estetica del manichino' narra come la visione di una ragazza troppo sottile abbia portato il poeta a contestarne la bulimia sorta per concorrere ai canoni estetici, di magrezza femminile, à la page. Questo per lamentare una violenza di messaggio, che spesso conduce i più fragili al pericolo. Viviamo circondati dalla violenza, si ricordino, per dire, i messaggi mainstream che squalificavano a priori una parte del dissenso popolare in nome della Scienza, generalizzando in un unico grande calderone d’idiozia le variegate tesi di questa. La pietà per l’esistente, dunque, è soprattutto una reazione alla violenza dei tempi corrivi. Il secondo testo tratta invece di immigrazione clandestina, cambia registro e fa ammettere all’io che quei derelitti sono compatiti in quanto v’è anzitutto una compassione di sé medesimo, uno specchiare il proprio dolore nel dolore dell’umanità. Pure nella finta-balordaggine della prima anta del dittico, insomma, il mio esperimento guardava a una via di liberazione ascetica della compassione, se pensiamo a Schopenhauer, che poi compresi essere troppo impegnativa: il singolo non può farsi carico del dolore di tutte le genti, del fil d’erba che muore, del fiore che viene privato del polline dall’ape, del topolino che va a sfamare il serpentello, etc. Non so se mi spiego, ma allora, la dialettica era: voglio avere compassione o sprezzo di questo dolore altrui che mi tocca? Meglio l’imperturbabilità, temo. Per concludere, arrivati a quest'ultimo raggiungimento (ho compassione perché mi compatisco) l'io prende in questo secondo 'capitolo' della nostra saga, a ridere delle proprie debolezze, a canzonarle, forse per alleggerirne il peso sull'animo, decostruendo così il narcisismo e decidendo di affrontare di petto certe deficienze (anche in amore) che tanto l'afflissero. È così che si arriva a un primo abbandono di sé con la poesia. Ero solo un innocente, e quindi, dopo ulteriore tempo e meditazione, a una vita nova che oggi sento pulsante".
Ezra Pound è il Maestro. Oltre a citare alcuni versi dal poemetto poundiano Hugh Selwyn Mauberley, scrivi “Mi sono ridotto come Ezra Pound” (da Aneddoto Personale), o ancora “Come fossi Ezra Pound infuriato coi suoi versi” (da In quel telefono che c’è?).
“Ez è stato il primo grande amore in poesia, non so se si è capito ma a me non sono mai piaciute le cose facili o superficiali, quindi, figuriamoci, a ventuno anni (e ancora facevo quinta Liceo, asino/non asino che ero!) presi a leggere i Cantos, a informarmi su Pound tramite interpreti quali Accame. Naturalmente, e questo era costume di molti, venni preso per fascista (pare essere di moda come termine), ciò mentre stavo contattando un pensatore che lottava coi versi per la pace tra gli uomini, pace che l’Usura non permetteva. Ma non commettiamo, vi prego, l’errore di credere che l’usura sia solo quella del Mercante di Venezia o delle banche: per Usura, al fine, intendiamo il capitalismo malato che Pound aveva compreso si sarebbe mangiato l’Occidente, privandolo quindi del senso di bellezza, sostituendo (anche e soprattutto in arte) la primazia dell’estetico con l’imperio del Mercato. Insomma, Pound, sulla carta mi fu maestro morale (lui, che si era creato confuciano), esempio di lotta per i propri ideali, anche a costo della perdita dei diritti, come fu per lui con l’imprigionamento in manicomio per circa quindici anni. I versi che citi, invece, raccontano due aneddoti: il primo riguarda un mio viaggio a Merano, per incontrare la figlia di Pound, dove la valigia, spostandosi nel baule, ha leggermente rovinato il quadro di Ez che intendevo portare in dono; l'altro invece si rifà a una famosa scena di Pound, che nella Laguna veneziana avrebbe gettato alle acque le copie della sua prima sillogina, 'A lume spento', sentendosi un poeta difettoso o di scarso valore. Facevo mia quella rabbia anche perché quando il verso non esce un poco ci si può scaldare. È tutta questione di voler dire e di non avere mai davvero linguaggio per mettere in parola compiuta quella cosa indicibile che è il sentito”.
Hai conosciuto la figlia di Ezra Pound, Mary de Rachewiltz, dunque. Immagino sia stata un’esperienza che rimarrà impressa nella tua memoria. Che ricordi hai di quel momento?
“Mary era deliziosa, una nonnina ultranovantenne simpatica ed energica come ce ne sono poche. Io ero molto emozionato trovandomi nel suo studiolo, e temo di essere apparso alquanto acerbo, ma lei fu lo stesso carina. Era probabilmente contenta di vedere un giovane italiano interessato a suo padre, il fatto è che di giovani americani di lì ne passano a iosa, ma di italiani non saprei. Era radiosa e mi riempì lo zaino di libri subito dopo avermeli dedicati. Mi diede anche quelli riguardanti il cosiddetto fascismo di Pound (che va sempre contestualizzato sul piano intellettuale, si badi) e disse: ‘Questi li tiri fuori solo una volta arrivato a casa’, ma io, promessa di marinaio, subito uscito dall’ingresso di Brunnenburg, mi misi a sfogliarli, al che mi sentii dire: ‘Lei è un indisciplinato!’, alzai lo sguardo e Mary stava scendendo il marciapiede di sanpietrini armata di bastone e di una gran risata. Io, un po’ sorridendo e un po’ arrossito, risposi che la tentazione di leggere le dediche era troppo forte. Quasi mi commuovo per la fortuna che ho avuto…”.
Chi sono gli altri maestri che hanno segnato la tua poetica?
"Sulla carta l’altro grande maestro è stato Vattimo, che ho conosciuto pure, ma questa è un'altra storia. Mentre nella vita di tutti i giorni i maestri sono stati, alla fin fine, tre. Non avrò mai abbastanza parole di riconoscenza per loro. Anzitutto Mario Marchisio, che quando ero ancora fondamentalmente analfabeta (nel campo delle lettere) mi prese sotto la sua ala per sbozzare, con un certo impeto, la pietra; successivamente, a limare il diamante, con maggiore pacatezza, è stato Franco Trinchero. Loro per quanto riguarda la poesia, per la filosofia il mio maestro fuori dall’accademia è stato Giancarlo Pagliasso, tra i primi interpreti dell’estetica vattimiana, che ritengo essere l’estetologo che meglio comprende le dinamiche che intercorrono tra il Mercato dell’arte e l’Arte. Insomma, è una lettura estetico - dialettica del Tardo Capitalistico, la sua. Con Marchisio, tornando ai primi due nomi, i punti di maggiore affinità sono nello humor nero e nella contemplazione della morte, che è quanto ci ha unito da principio; con Trinchero invece c'è in comune una tendenza al diarismo trasfigurato in toni per lo più grotteschi, questo ad affievolire ogni pretesa di lettura forte dell'esistenza umana (l'essere nel mondo heideggeriano). Chissà che non mi bastonino, ora".
Quando hai incontrato le Muse della poesia per la prima volta?
“Ammettendo che le Muse siano quell’eco d’infinito nella poesia scritta, quel senso di alterità profonda, sovrasensibile, direi poche volte e quasi sempre leggendo altri poeti, per lo più lirici dai toni sublimi. Se invece intendi, più comunemente, ‘quando hai scritto per la prima volta qualcosa di decente?’, direi: quando morì il mio amato gatto, Cristoforo. Il dolore era così acuto e duraturo (poi passato solo grazie a una nuova creatura a curare) che sentii di dover scrivere qualcosa, nacque così la prima poesia che conservai, in apertura poi del mio esordio in poesia, che presto intendo rieditare in forma migliore. Si trattava comunque di un libretto dai chiari toni crepuscolari, in cui l’ossessione per la morte (che alcuni mi dicono sterile o stucchevole) abitava e invalidava una giovinezza non troppo in comunione col Tutto. Pensiamo a Ungaretti, orsù: 'Il mio supplizio / È quando / Non mi credo / In armonia' (da I fiumi)”.
Credo che oggi ci sia davvero bisogno di Poesia. Chi è il poeta oggi? Qual è il suo compito, ammesso che ne abbia uno?
“C'è chi potrebbe dirti, a mo' di vate, o tribuno del popolo, che il poeta oggi è qualcuno che viene chiamato a restituire bellezza agli uomini; altri direbbero che il poeta è un tipo figo che dice a memoria due versicoli schifosi mostrando la tartaruga; altri ancora che è poesia arrostire la carne sulla brace o fare un ruttino dopo aver bevuto la Coca Cola. Io sinceramente non lo so, mi ritengo (giacché mi ritengono) un esteta e un intellettuale ma non mi sento chiamato a divulgare il mio poco sapere quando non richiesto, manco d’una tale supponenza, né mi appassiona l’idea di illudere i meno colti che sia poesia quanto poesia non è, meno ancora dire che qualsiasi atto performativo possa raggiungere dimensioni artistiche. Ho forse un’idea vetusta della materia? Ma indubbiamente! Eppure, da quello che ho visto, per fare poesia bisogna farsi il mazzo, andare a bottega e studiare. Non si fa niente senza studio e forse nemmeno senza predisposizione, perché, diciamolo, pur con tutta la buona volontà, c’è gente che non ce la fa proprio a dire cose intelligenti. E non è colpa di nessuno, spero”.
Sei anche un filosofo. Stai facendo la tesi sul pensiero di Gianni Vattimo, è corretto?
“Sì, work in progress. Però col 'filosofo' andiamoci cauti, sono uno studentello, in fondo. Mi trovo comunque a buon punto e si tratta di una tesi sull’estetica vattimiana: parto dal dominio crociano che viene soppiantato da Luigi Pareyson e mi spingo ben oltre l’apporto di Vattimo, ossia alle sue declinazioni poetico-figurative e, a mio dire, anche letterarie. Sento il peso di un lavoro che, nella mia testa, vuole avere carattere di novità e di ricerca".
E sei un artista. Con i tuoi autoritratti, dipinti e scolpiti, guardi e cerchi te stesso con la stessa cinica ironia della tua poesia. Per la copertina di "Pena di me stesso" però hai scelto un ritratto realizzato dall’artista e tuo amico Gabriele Scarpelli ("Deformazione di Pera").
"Sì, l’opera di Gabriele era azzeccatissima per stare in copertina al libro, inizialmente avrei voluto qualcosa che richiamasse la metafora interna al testo, quella del monaco stilita, poi ebbi l'illuminazione: 'Devo mettere quello pseudo-Bacon dello Scarpelli!', e così fu. Sulla mia 'arte' ho dei rimpianti, in quanto è rimasta un po’ da parte da quando mi concentro sulle lettere e sulla filosofia. Ci fu un momento molto doloroso, a inizio università: ragionavo di lasciare perdere e di andare a fare Belle Arti, ma infine, caparbio, testone, ho resistito e mi sono fatto quindi 'modificare'. Diciamo questo, e dici bene: la mia attenzione è sempre stata anzitutto per i volti, e quindi il mio su tutti. Amavo metterlo al posto di quello dei quadri più iconici, deformandolo di volta in volta a sottolineare una frammentarietà dell’io. Sarà dunque anche la mia pittura una ‘pena di me stesso’? Forse".
Francesca Barbero
 CANALE
CANALE Ezra Pound - Pena di me stesso - Paolo Pera
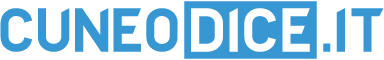

 Condividi
Condividi