Femia al Ponte del Dialogo di Dronero: "Nel nostro lavoro è necessario dare importanza alle parole"
L'architetto, autore di opere come il Docks di Marsiglia e la nuova sede BNL-BNP Paribas a Roma, ha parlato del concetto di città buona e della centralità del "tempo lungo"La prima e intensa giornata del Ponte del Dialogo di Dronero si è chiusa ieri sera con l’evento “La città buona: Dronero tra presente e futuro”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Prometheus. Ospite d’eccezione è stato l’architetto Alfonso Femia, noto per le sue opere di grande impatto, come i Docks di Marsiglia, il nuovo Palazzo del Cinema di Venezia e la sede BNL-BNP Paribas a Roma. Il suo intervento ha affrontato il tema della città non come questione politica, ma come il risultato delle scelte di persone che decidono di trovarsi in un determinato luogo in un preciso momento. Fin dall’inizio, Femia ha voluto sottolineare l’importanza del termine "progetto", evidenziando come questa parola spesso non riceva la giusta profondità di significato. “Nel nostro lavoro abbiamo cercato di dare importanza alle parole. Oggi esiste un rapporto sempre meno profondo tra l’uso delle parole e il loro significato. Il titolo La città buona è legato anche al racconto della città in un momento storico come quello della pandemia. Cerchiamo di ridare centralità al concetto di relazionalità”.
Secondo Femia, il progetto di una città non deve nascere con l’intento di fornire risposte definitive, ma piuttosto con l’obiettivo di porre le giuste domande. Un tema particolarmente rilevante riguarda il cambiamento demografico, che ha ribaltato radicalmente la distribuzione della popolazione: “Negli ultimi cinquant’anni si è passati dall’85% degli abitanti nelle campagne all’esatto opposto. Nei prossimi anni la maggior parte della popolazione sarà concentrata nelle cosiddette megalopoli”. Diventa quindi necessario capire le dinamiche, che possono essere molteplici. Ma soprattutto, in questo quadro, va inserita l’idea del tempo lungo. È un controsenso, se si pensa a un mondo che corre con la quinta marcia ingranata, ma non deve essere così per Femia. “Occorre introdurre un tempo lento al fianco del tempo veloce che la quotidianità impone. Occorre farlo ritornando a osservare, ascoltare, a guardare l’invisibile”. Immaginare la città buona è possibile, secondo l’architetto. Il concetto nasce come una riflessione durante la pandemia di Covid-19, un periodo in cui gli abitanti erano “arrabbiati” con la città, perché non li aveva aiutati. “In questo disagio legittimo, però, c’era un tema. Noi dimenticavamo che la città fosse un centro di relazioni. Deve essere un sistema di grande generosità. Da qui nasce un quesito: che idea abbiamo della città? La città è pubblica, è un’idea di comunità. Allora bisogna cambiare lo sguardo”. Deve essere in grado di fornire risposte reciproche e, quando ci riesce, diventa un luogo che appartiene al cittadino stesso.
Un concetto importante per Alfonso Femia è anche quello di tempo. “Genova e l’incontro in università mi hanno spinto ad approcciare questa carriera. Ho scelto architettura perché pensavo che potesse avere una dimensione umanistica importante. Studiare qualcosa che mi portasse a incontrare città, persone e luoghi. Nel mio studio dico ai ragazzi di crescere un millimetro al giorno. Non pensare al grande salto. L’idea è che questo mestiere sia basato sul tempo lungo, ma oggi viviamo in un mondo che non ne riconosce l’importanza. Anche quando si tratta di passare il testimone, non devi farlo all’ultimo secondo, ma nel momento in cui stai meglio. Perché così dai tempo lungo, dato che non puoi prevedere ciò che può succedere. Come l’acqua. All’Università di Pisa è stato coniato il neologismo tempo d’acqua. È un tema che richiede tempo e conoscenza. Siamo diventati una società puramente esperienziale. Non c’è più la volontà di lavorare in profondità. E la profondità ha bisogno di tempo, soprattutto in un contesto sociale in cui le cose cambiano così velocemente”.
Da qui, Femia fa un collegamento con un argomento non abbastanza trattato durante la pandemia: come cambierà il lavoro? Quel tema è stato discusso, ma secondo l’architetto non è stata data la giusta importanza alla scuola, che ricopre l’ultima grande funzione pubblica e che deve essere alla base del concetto di città buona. “Sta a noi creare uno spazio dinamico all’interno della scuola, che non si misuri più nella durata delle lezioni, ma che faccia parte della città. Che funzioni come luogo di aggregazione e ritrovo”. Un corpo che, in qualche modo, sia legato alla città, cosa che lui sottolinea con questa frase: “È la strada che attraversa lo spazio della scuola. Sembra una banalità, ma cambia i rapporti e anche la percezione. La percezione ti porta alla curiosità, ad analizzare. Ma non è quello che succede oggi. Bisogna avere anche la pazienza di vedere maturare ciò. La scuola deve essere questo. Una volta, a Torino, alcuni ragazzi mi dissero che per loro la scuola era chiusa anche quando era aperta. Questo indicava perfettamente che gli studenti non si identificavano nella scuola perché non soddisfaceva le loro esigenze relazionali. Una scuola di questo tipo, invece, permette di creare un’economia sociale”.
Piero Coletta
 DRONERO
DRONERO Dronero - Ponte del dialogo - alfonso femia
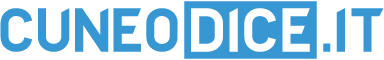
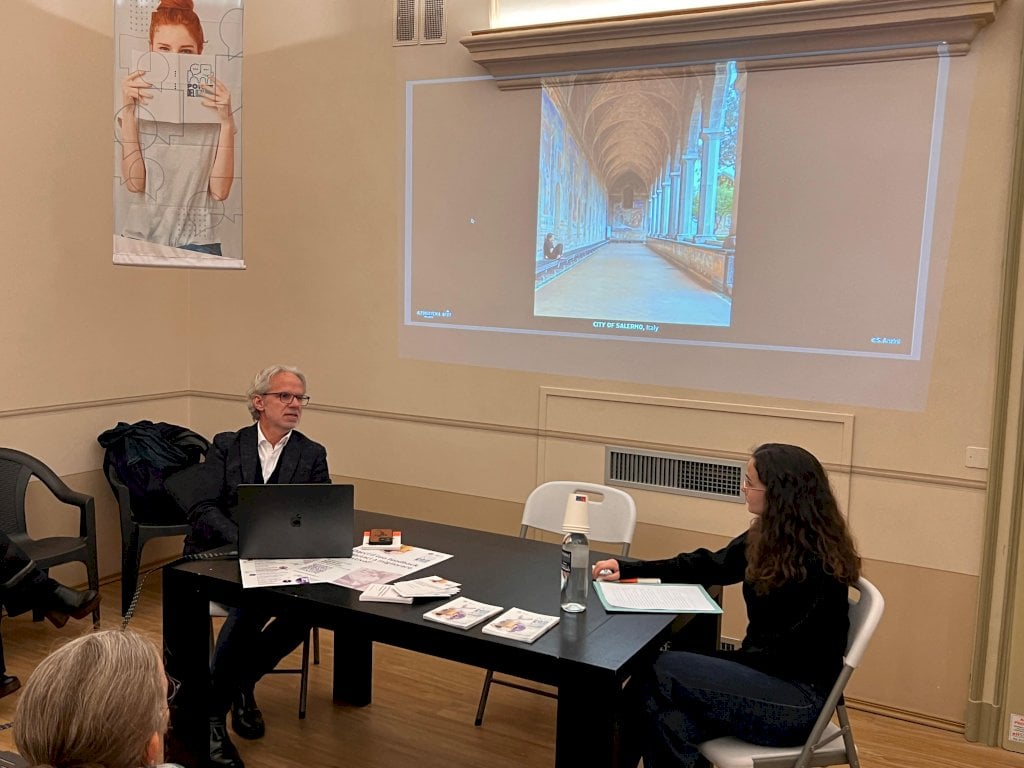
 Condividi
Condividi